
Il mercato mondiale degli armamenti
 a cura dell’On. Silvana Pisa Senatrice del gruppo ULIVO della repubblica Italiana
a cura dell’On. Silvana Pisa Senatrice del gruppo ULIVO della repubblica Italiana
Il SIPRI di Stoccolma stima il valore finanziario del commercio mondiale degli armamenti in una forchetta compresa tra i 39 e i 56 miliardi di dollari. Una stima naturalmente molto approssimativa, in considerazione del fatto che i dati ufficiali resi disponibili sono molto diversi. Inoltre vi sono rilevanti differenze quando i confronti sono fatti sul valore dei contratti stipulati piuttosto che sulle esportazioni effettive di armamenti.Il registro sui trasferimenti di armi convenzionali tenuto dall’Onu dovrebbe essere uno strumento di conoscenza e di confidence building nei rapporti tra Stati. In realtà, negli oltre dieci anni di esistenza e nonostante siano ben 117 i Paesi che accettano di fornire informazioni a questo registro, le informazioni che si possono ricavare sono di pochissima utilità almeno dal punto di vista della valutazione della dimensione globale del mercato degli armamenti o degli effettivi trasferimenti di materiale da guerra da Paese a Paese. Infatti nel registro sono indicate solamente le vendite o le cessioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie di calibro superiore ai 75 mm., aerei da combattimento, elicotteri da attacco, navi da guerra di dislocamento superiore alle 500 tonnellate e missili e razzi, guidati o non guidati. A titolo di esempio, nel 2005 l’Italia ha dichiarato – sulla base dei criteri fissati dallo stesso registro – al registro Onu una sola esportazione (2 unità navali classe Lupo ex Marina Militare, vendute al Perù) e due importazioni (26 veicoli cingolati BV 206 dalla Svezia e 807 missili Milan dalla Francia). Una parte minima, dunque, dei trasferimenti effettivi di armi in esportazione ed in importazione.Per quanto riguarda le tendenze del mercato stesso, sempre con riferimento ai dati elaborati dal SIPRI e riferiti ai valori monetari costanti 2005 del dollaro statunitense, il commercio internazionale degli armamenti presenta dal 2001 una curva ascendente piuttosto accentuata dopo alcuni anni di forte ribasso. Prendendo a base i valori massimi delle esportazioni globali calcolate dall’Istituto svedese possiamo notare come nel 2001 si fosse raggiunto un minimo quinquennale di 35,9 miliardi di dollari. Nel 2005 il valore scambiato ha raggiunto invece i 56 miliardi, con un incremento di 20 miliardi in valore assoluto e di circa il 56% in valore relativo. La classifica dei maggiori Paesi esportatori non subisce grandi modificazioni da almeno un ventennio, durante il quale gli Stati Uniti hanno costantemente detenuto il primato delle vendite totali (nel 2005 calcolate dal SIPRI in 7083 milioni di dollari), seguiti dalla Russia (6623), Francia (2050), Germania (1533), Gran Bretagna (912), Olanda (877) e Italia (787), con movimenti congiunturali in alto e in basso degli ultimi quattro. Tra gli altri Paesi, sono forti esportatori Israele, l’Ucraina, il Canada e la Spagna con la Cina il cui commercio di armi sta crescendo moltissimo. Tra i Paesi importatori, mentre diventa sempre minore il peso di Stati come l’Arabia Saudita, un tempo tra i più gradi acquirenti del mondo, crescono in valore il mercato indiano, quello cinese e quelli di Grecia, Israele, Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti.
La situazione in Italia
Nel metodo
La relazione 2006 mostra una migliore leggibilità rispetto a quelle degli anni precedenti ed evidenzia uno sforzo di trasparenza, sia pure ancora insufficiente. In particolare sembra necessario che la relazione illustri con maggiore dettaglio quali siano i materiali d’armamento autorizzati per Paese, indicando, almeno per le forniture principali, il dettaglio sui materiali venduti e non solo le categorie nelle quali questi rientrano (tabella P, volume I). Non solo: è apprezzabile il fatto che la relazione del 2007 contenga la novità positiva di trasmettere l’elenco dei Paesi cui è vietata l’esportazione con relativi embarghi. Inizialmente, all’interno della Relazione annuale del Presidente del Consiglio al Parlamento sulle esportazioni di armi, era allegata una tabella sbagliata. A scoprirlo è stato Giorgio Beretta (di Archivio Disarmo), che ne ha avvisato il Governo che successivamente l’ha cambiata. Si tratta della tabella “M” degli allegati, in cui si riassume l’andamento delle autorizzazioni alle esportazioni definitive e alle operazioni di esportazioni d’armamento nel periodo 1997-2006. A causa di un calcolo errato nella rivalutazione del coefficiente monetario, nella prima versione (quella sbagliata diffusa con la Relazione), l’andamento mostrava una sostanziale flessione negli anni 2000-2005. Al contrario, la seconda versione, (rivista e corretta e già disponibile sul sito del governo), la flessione in discussione si limita agli ani 2000-2002 per poi salire nel 2004 oltre i record toccati nel 1998. (vedi tabella allegata).
Nel merito
Il grafico delle esportazioni d’armi dell’Italia (vedi tabella M, volume I della Relazione), è quasi perfettamente sovrapponibile a quello mondiale, così come descritto dal SIPRI, con una linea tendenziale negativa fino al 2002, seguita da un forte aumento che sembra perdurare anche nel 2007. Nel 2006 l’attività di esportazione di armamenti da parte del nostro Paese è definita dai seguenti dati globali:
Esportazioni autorizzate 2006 € 2.192.402.944
Esportazioni autorizzate 2005 € 1.360.698.213
Differenza in valore + € 831.704.731
Differenza percentuale + 61,12
Il notevole incremento anno su anno delle esportazioni italiane (si tratta naturalmente sempre di autorizzazioni, non di esportazioni effettive che hanno una diversa dinamica) è in parte da ricondursi al contratto per la fornitura di elicotteri AgustaWestland per la flotta presidenziale statunitense e in parte ad una maggiore attività esportativa di tutto il settore. Tale maggiore attività corrisponde, come si è visto, ad una generale congiuntura favorevole del mercato mondiale degli armamenti che strutturalmente ha una forte componente di ciclicità. Si tratta di un mercato molto condizionato dalla specificità del prodotto militare che abbisogna in genere, a prescindere dalla tipologia, di lunghi, talvolta lunghissimi cicli di sviluppo e tempi di approvvigionamento che spesso superano il decennio.Attualmente il mercato mondiale degli armamenti si trova in una fase espansiva perché moltissimi sistemi d’arma sono giunti al termine della vita tecnica e richiedono una sostituzione. Contemporaneamente alcune importanti realtà geopolitiche hanno avviato un significativo aumento degli armamenti in concomitanza con la loro sempre maggiore rilevanza sul piano politico-economico. Ci si riferisce in particolare all’India (nell’ultimo quinquennio ha importato armi per 10,14 miliardi di dollari, un livello equivalente agli acquisti effettuati durante gli anni di maggior intensità del conflitto con il Pakistan), alla Cina (14,61 miliardi di dollari nel quinquennio 2002-2006, pari a circa il 50% delle importazioni d’armi di Pechino degli ultimi trent’anni), gli Emirati Arabi Uniti (7 miliardi di dollari, anche in questo caso equivalenti a circa la metà del valore delle importazioni dell’ultimo trentennio) (elaborazione su dati SIPRI). Rispetto alla distribuzione geografica delle esportazioni, il caso italiano registra un andamento che sembra seguire solo in parte il generale andamento del mercato mondiale degli armamenti. Infatti, nel 2006, le esportazioni italiane verso le aree geografiche più attive si sono attestate a livelli molto bassi, con la sola eccezione degli Emirati, secondo cliente in ordine di importanza dopo gli Stati Uniti, con ordini autorizzati per 338 milioni di € pari al 15,42% del totale dei contratti. Cina, India e in genere tutta l’area dell’Estremo Oriente sono sostanzialmente assenti dal pacchetto di ordini dell’industria italiana. La relazione 2006 individua nella permanenza dell’embargo all’export di armamenti nei confronti della Cina la causa principale di tale situazione (le commesse verso Pechino rappresentano solo lo 0,08% del totale), ma non spiega l’assenza di altri mercati che risentono probabilmente di una scarsa iniziativa governativa di sostegno all’esportazione, iniziativa che invece non è mancata, con il governo Berlusconi, nei confronti degli Stati Uniti. Da segnalare tuttavia l’attivismo italiano, soprattutto nei confronti dell’Ue, per la revoca dell’embargo nelle esportazioni d’armi alla Cina: dalla dichiarazione del presidente Ciampi durante la visita in Cina del dicembre 2004, alle sollecitazione del presidente del Consiglio Berlusconi a vari Consigli della Ue, fino alle dichiarazioni ufficiali del presidente del Consiglio Romano Prodi in occasione della sua visita a Pechino nel settembre 2006. In termini di destinazione delle commesse, nel 2006 si accentua il peso di quelle verso i Paesi della Nato e dell’Ue, che rappresentano ben il 63,68% del totale, contro il 55,58% del 2005. A determinare questa percentuale sono soprattutto le commesse verso gli Usa (che nel prossimo anno aumenteranno ulteriormente considerato l’ultimo contratto firmato da Fnmeccanica per 78 veicoli JCA – C27J) e i Paesi di nuova accessione a Nato e Ue come la Polonia (ben il 10,38% del totale). Nel 2005 la Polonia non era nemmeno tra i primi dieci importatori di armamenti italiani, come non lo erano la Bulgaria e la Lituania che invece vi figurano nel 2006. Dal punto di vista strutturale dell’offerta si conferma la radicalizzazione di una distribuzione delle commesse agli estremi della scala in termini di controvalore finanziario e di numero di licenze concesse. In sostanza, se si considerano le autorizzazioni concesse in termini quantitativi, ben il 96,27% (nel 2005: 95,98) delle 1183 autorizzazioni è relativo a commesse di valore inferiore ai 10 milioni € e rappresentano il 25,09% del valore totale. Al contrario 12 sole autorizzazioni (l’ 1,40% del totale) rappresentano il 51,01 per cento del valore di tutte e esportazioni 2006.Il dato 2006 mostra una decisa accentuazione di una tendenza già evidente negli anni precedenti, quando tuttavia le esportazioni di beni per un valore compreso tra i 10 e i 50 milioni € costituivano il 43,96% delle commesse (quest’anno sono solo il 23,90 del valore totale). È probabile che questo fenomeno di consolidamento degli estremi della scala di valore si accentui nei prossimi anni con una incidenza ancora più squilibrata del segmento alto. La riorganizzazione in atto dell’industria italiana ed europea, con il forte attivismo di Finmeccanica, tende a privilegiare i grandi attori. L’industria degli armamenti, così come del resto gran parte delle attività economiche nella produzione e nei servizi, tende infatti a costituire aggregati sempre più grandi e sempre più transnazionali per competer meglio sul mercato globale anche o considerazione che i mercati domestici sono sempre meno protetti e tendono a diventare sempre più piccoli. Così sono dieci aziende che si dividono la metà delle esportazioni: tra loro Agusta, Alenia, Oto Melara, Selex che si alternano, anno dopo anno, alla guida di questa classifica. Si tratta di aziende tutte riconducibili al gruppo Finmeccanica, holding di Stato, che mettono il Governo in una oggettiva situazione di conflitto di interessi quando si tratta di accordare o negare una autorizzazione all’esportazione, perché lo Stato è allo stesso tempo controllore e padrone dell’azienda controllata. Anche se in anni recenti non sono state segnalate violazioni significative della normativa sulle armi, tuttavia non vi è dubbio che l’attuale situazione si presta a notevoli ambiguità.
Questa lettura della relazione governativa non deve far dimenticare che in realtà questo commercio riguarda un oggetto che neutrale non è: si tratta del commercio di armi che è un commercio che ha lo scopo di produrre morte. Il raddoppio delle esportazioni di armi equivale ad un raddoppio dell’esportazione di un potenziale di morte. Ed è per questo che la legge 185 sottopone a controlli di trasparenza il commercio e l’esportazione delle armi e per questo stesso motivo è necessario che il Governo affronti e risolva le criticità di seguito esposte.
Problemi Aperti
L’applicazione di percorsi preferenziali riservati a paesi UE e NATO ad altri paesi.
La prassi di firmare accordi bilaterali di collaborazione nel campo degli equipaggiamenti militari con i piú diversi paesi, inserendovi le clausole che potenzialmente li qualificano come “apposite intese intergovernative” ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 185/90, è andata crescendo nell’ultimo decennio. Con le modifiche apportate al Regolamento di esecuzione nel 1997 si è cercato di arginare questo atteggiamento, ma senza risultati. Va ricordato che nella scorsa legislatura nella Commissione Esteri della Camera vi sono stati ripetuti interventi contro questa prassi, in particolare da parte dell’ex-Ministro della Difesa Mattarella. Sembrerebbe opportuno che il Parlamento richiamasse l’attenzione del Ministro Parisi su questo tema, anche con un’eventuale mozione.
Riconversione
La tendenza alla concentrazione delle produzioni militari in realtà allo stesso tempo multinazionali e di dimensioni sempre più ampie, diventa un ulteriore ostacolo a quel processo di mancata conversione delle produzioni militari che è uno degli obiettivi dimenticati della legge 185, fissati al comma 3 dell’articolo 1, dove sono previste «misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie del settore della difesa». Ne prende atto la stessa relazione 2006 (pagina 15 del I Volume) che afferma come «l’esperienza ha dimostrato la non convenienza ad avviare processi di riconversione…. Nei casi in cui il processo è stato perfezionato, il saldo economico-industriale è stato assolutamente negativo ed a totale carico dello Stato». Una riflessione meriterebbe il criterio richiamato della “convenienza”. Non solo per quello che riguarda l’obiettivo previsto dalla legge ma anche per quello che concerne gli esiti occupazionali del settore: perché se è indubbio che la produzione e il commercio di armi producono PIL occorre riconoscere che la positiva ricaduta occupazionale che si registra nelle industrie della difesa a seguito di investimenti sarebbe comunque significativamente minore della crescita occupazionale che si avrebbe – a parità di investimenti – in altri comparti. In secondo luogo, come è dimostrato dagli andamenti storici, il settore militare è caratterizzato da andamenti ciclici, per cui può passare repentinamente dalle stelle alle stalle. E’ necessario su questo un forte impegno: meno elicotteri antiguerriglia e anticarro Agusta, e più elicotteri Agusta in versione sanitaria o per la Protezione Civile (siamo il Paese che in Europa produce la maggior quantità di elicotteri in versione sanitaria, ma anche quello che ne fa il minor uso). Questa “dote alternativa” alla domanda militare di tipo civile, è essenziale per poter garantire continuità produttiva, e quindi occupazionale, alle aziende della difesa: d’altra parte, se in tempo di guerra è sempre stato possibile trasformare le aziende civili in aziende a produzione militare, perché in tempo di Pace non è possibile fare il contrario? Migliori le prospettive della diversificazione produttiva dove, sottolinea la relazione, le ricadute non sono più «solo a senso unico dal militare al civile». In altre parole viene indicato come auspicabile e in un certo senso maggiormente percorribile un percorso inverso da quello indicato dalla legge. Da tenere presente, peraltro, che la legge non sollecita affatto la riconversione come antidoto a eventuali crisi aziendali o settoriali, ma come misura generale di costruzione di una società e di una cultura che fa della pace un valore di riferimento assoluto e non solo un auspicio verbale. La relazione prende atto che questo processo non si è compiuto. Anzi, proprio i processi di concentrazione in atto tendono a ridurre proprio la diversificazione produttiva. L’assorbimento, ad esempio, della società Datamat in Finmeccanica sta portando ad una ristrutturazione delle attività della stessa all’interno della neo-costituita Elsag Datamat in senso di un potenziamento proprio del comparto difesa (che già rappresentava il 44% del fatturato di Datamat) e sicurezza, con una diluizione delle attività di ricerca e produzione negli altri comparti a prevalente vocazione civile. La relazione conclude dando per acquisita la sostanziale cessazione di qualsiasi attività istituzionale nel senso indicato all’articolo 1 della 185, giustificandola con i limiti imposti dalla libera concorrenza e dalle direttive comunitarie e lasciando tale responsabilità ad eventuali, autonome iniziative aziendali. In ideale continuità con queste valutazioni, vi è la segnalazione da parte della relazione di un fenomeno opposto a quello della riconversione/diversificazione in senso civile, e cioè il crescere del numero delle aziende iscritte nell’apposito registro dei produttori di armamenti ed equipaggiamenti per uso militare. Nel 2006, infatti, sono state iscritte nel Registro nazionale delle imprese previsto dall’articolo 3 della legge 185 ben 21 nuove aziende, portando il totale delle iscrizioni a 187, con un saldo positivo (al netto di 11 cancellazioni) di 10 aziende rispetto all’anno precedente. Nel 2005 le nuove iscrizioni furono 13, così come nel 2004. La tendenza dunque è verso un aumento, anche piuttosto consistente, della aziende produttrici di materiali di armamento il che fa ritenere probabile nei prossimi anni un impatto anche sulla dimensione del valore totale delle esportazioni militari.
Le armi leggere
Nessuno sa quante armi leggere ci sono al monto. Ufficialmente sono registrare 17.238.615 armi militari e di polizia. Eppure, secondo un’inchiesta svolta nel 2006 dall’Istituto di studi internazionali di Ginevra, il numero effettivo sarebbe dieci volte più grande: 226,3 milioni di unità. A queste si devono aggiungere tutte le armi private, oltre agli otto milioni di nuove armi prodotte ogni anno. Secondo l’Unicef in tutto sarebbero circa 600 milioni. Sempre secondo l’Unicef e il Centro internazionale della conversione di Bonn (Bicc), un’organizzazione internazionale non profit, il 90 percento dei morti in guerra degli ultimi dieci anni è stato ucciso da mitra, pistole automatiche o altre piccole armi. I fucili si trovano nuovi o usati. Resistono a tutte le guerre, e finché l’ONU non li fa schiacciare dai suoi mezzi cingolati, non si guastano praticamente mai. Perciò le armi leggere viaggiano da una guerra civile all’altra. Occorre ricordare, che ogni anno in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina si spendono mediamente 22 miliardi di dollari per l’acquisto di armi, una somma che avrebbe permesso a questi paesi di mettersi in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio come l’eliminazione dell’analfabetismo (costo stimato in 10 miliardi di dollari l’anno) e nella riduzione della mortalità infantile e materna (costo stimato in 12 miliardi di dollari l’anno). Secondo Small Arms Survey, l’Italia è il secondo esportatore al mondo di armi leggere e di piccolo calibro. È aperta la questione importantissima dei trasferimenti di armi cosiddette leggere e delle armi “comuni” da sparo, sottratte alla disciplina della 185 e che costituiscono uno dei maggiori problemi a livello mondiale per quanto riguarda il controllo dei conflitti. Problema aperto anche per l’incapacità delle Nazioni Unite di addivenire ad accordi specifici in questione, in particolare a conclusione della Conferenza di riesame del Programma di azione delle Nazioni unite sul traffico illecito delle armi piccole e leggere (giugno-luglio 2006).
Amnesty international promosse la campagna “control arms” per chiedere un trattato internazionale sul commercio delle armi per introdurre controlli e paletti sul commercio di queste armi, pur avendo raccolto più di un milione di adesioni, non è stata accolta, la scorsa estate, nella conferenza mondiale dell’ONU sulle armi leggere nonostante l’adesione della maggior parte dei governi tra cui l’Unione Europea e i paesi africani e latino-americani (153 sono stati gli stati che hanno votato a favore; 24 quelli che si sono astenuti; 1 solo lo stato che ha votato contrario: gli Stati Uniti). Anche nell’ambito della 61ma sessione dell’Assemblea generale dell’Onu nessun passo concreto, salvo la decisone di convocare per il 2008 una riunione ad hoc (pagina 8, volume II, Relazione del Ministero degli Affari Esteri). Si tratta di un mercato enorme, lo UN Office for the Cordination of Humanitarian Affaire valuta in 4 miliardi di dollari il valore globale di questo mercato, di cui almeno 1 miliardo generato dal mercato nero e illegale, il che significa decine, forse centinaia di milioni di armi vendute considerando il basso valore unitario di ciascuna. La stessa relazione del Ministero degli Esteri sottolinea come, pur in assenza di una normativa specifica, il Ministero degli Interni, al quale fa capo l’attività relativa alle esportazioni delle armi leggere, si è più volte coordinato con l’ufficio della Farnesina per le autorizzazioni dei materiali di armamento. Tale coordinamento si deve sia al fatto che queste armi rientrano nelle tipologie previste dal Codice di condotta UE sia probabilmente per la maggior attenzione posta a livello internazionale nella lotta al terrorismo. Resta tuttavia l’esigenza di addivenire ad una specifica normativa nazionale che sottragga alla discrezionalità amministrativa il rilascio di autorizzazioni per queste armi. (pagina 3, volume II, Relazione del Ministero degli Affari Esteri). Nella relazione si parla di richieste di pareri rivolte dal Ministero dell’Interno in merito e di consultazioni con gli altri Paesi europei per coordinarsi in base al Codice di Condotta europeo, senza però che nella relazione venga detto nulla al riguardo. Pertanto è importante chiarire se la norma predetta (art. 15, comma 7 della legge 185) sia stata applicata ed in caso affermativo verso quali paesi. Per quanto si è detto sulla delicatezza della materia e in coerenza col dibattico che si sta sviluppando alle Nazioni Unite si ritiene indispensabile estendere alle “armi leggere” principi e controlli all’export analoghi a quelli previsti dalla legge 185 del ’90 e di consentire maggiori livelli di trasparenza e informazione per il Parlamento.
La dimensione europea e sovranazionale
A livello europeo è sempre più forte la spinta verso la costituzione di un mercato unico anche per i materiali destinati alla difesa. Il 7 dicembre 2006, il commissario europeo al mercato interno, Charlie McGreevy, ha annunciato l’adozione da parte della Commissione di una “comunicazione interpretativa” del trattato europeo per quanto riguarda le deroghe in materia di acquisto di armamenti e materiali per la difesa da parte degli Stati membri. La comunicazione intende restringere i casi di ricorso alle deroghe, aprendo così il mercato interno europeo della difesa alla competizione. Secondo la Commissione, le spese per la difesa dei 27 Paesi dell’Unione ammontano annualmente a circa 170 miliardi € (pari all’1,7 per cento del Pil). Di questi, circa 82 miliardi (0,8% del Pil) costituiscono spese per acquisti di beni e servizi destinati alle forze armate e 30 miliardi (0,3% del Pil) sono spese propriamente per armamenti. Obiettivo della Commissione è di giungere ad un vero e proprio European Defence Equipment Market (EDEM) che completi le iniziative comunitarie nel campo della sicurezza e della difesa. La comunicazioni interpretativa integra il codice di condotta volontario adottato da 22 Paesi (non hanno aderito Spagna e Ungheria) che fanno parte della Agenzia europea di difesa con il quale i partecipanti si impegnano a pubblicare attraverso l’Agenzia stessa i contratti di acquisizione di armamenti o equipaggiamenti di valore superiore al milione di euro. L’azione della Commissione in questo settore di fatto è poco più di una presa d’atto di una situazione che vede quasi tutte le aziende del settore di un certo rilievo essere parte di gruppi multinazionali, tanto da avere per lo più perso le caratteristiche identitarie che ne definiscono la nazionalità. Una situazione che può rendere difficile determinare, ad esempio, sotto quale regime nazionale ricada un’esportazione, a meno che non si assuma come criterio solo quello del luogo di produzione fisica di un bene. Il caso di scuola è proprio quello degli elicotteri Agusta Westland, una società italiana che ha recentemente trasferito la sua divisione militare in Gran Bretagna. Oppure che può avere implicazioni a livello dell’operatività stessa dell’azienda quando sono implicate unità produttive situate in Paesi diversi. L’accordo di Farnborough (recepito nella legislazione italiana con la legge 148/2003 che ha modificato la 185/1990), che istituisce la cosiddetta Licenza globale di progetto, non ha avuto effetti pratici concreti, almeno per quanto riguarda l’Italia. La relazione 2006 segnala infatti che nessuna autorizzazione è stata rilasciata in base alla nuova normativa. Tuttavia, sia la Commissione europea che i firmatari della convezione di Farnborough (Francia, Germania. Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito), hanno avviato iniziative separate per giungere alla formalizzazione di “licenze generali” destinate (secondo quanto riporta la Relazione, Volume I, pagina 19) «ad imprese “qualificate” per poter movimentare componenti militari predefiniti verso altre imprese europee “qualificate” a condizione che i prodotti finali siano destinati solo a Paesi europei o ad altri Paesi preventivamente concordati fra i Paesi coinvolti nella produzione». L’eventuale istituzione della “licenza generale” corrisponderebbe, di fatto, alla creazione di un mercato unico anche nel campo della difesa, sia pure con tutti i limiti che in un primo tempo verrebbero fissati, ma la cui concreta applicazione sarebbe, al meglio, difficoltosa per quanto riguarda le autorizzazioni all’export verso Paesi extracomunitari. D’altronde diventa difficile non prendere atto di una situazione dove di fatto non esistono più aziende nazionali “pure” e che può comportare la spinta a delocalizzare le produzioni “sensibili” verso quei Paesi con minori vincoli all’export. È vero che il Codice europeo di condotta tende ad unificare i comportamenti dei singoli Stati nazionali in materia di autorizzazioni all’esportazione di armamenti. Ma si tratta di un codice che non prevede sanzioni calibrato sui requisiti minimi di garanzie sull’esportazione, certamente meno rigidi di quelli previsti dalla legislazione nazionale italiana. Diventa dunque imperativa un’azione politica e legislativa che, mentre prende atto della mutata realtà produttiva e di mercato, non consenta che sia questo stesso mercato a determinare anche le proprie regole, muovendosi verso quei contesti nazionali di “minore resistenza”. Da questo punto di vista, particolare attenzione dovrà essere posta a quei Paesi di nuova accessione all’Unione che sembrano presentare caratteristiche sia politiche che di mercato interno del lavoro che potrebbero favorire eventuali delocalizzazioni interne, anche parziali, di produzioni “sensibili”.
Gli intermediari
Resta da definire una normativa nazionale che definisca, regolamenti e controlli le attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti. In tale ambito esiste una Posizione Comune dell’Ue che tuttavia non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale. Si tratta tuttavia di un provvedimento necessario ed urgente, soprattutto – ma non solo – in relazione alla problematica delle armi leggere (pagina 17, volume I). Il lavoro dell’intermediario consiste nel riunire il compratore, il venditore, il trasportatore, il finanziatore e l’assicuratore per organizzare i trasferimenti di armi e munizioni. La transazione si svolge su un territorio in cui le armi non entreranno mai, e l’intermediario non ne è mai il proprietario. In questo modo è facile per tutte la parti aggirare i regolamenti nazionali. Sebbene alcuni Stati europei abbiano messo in atto una regolamentazione relativa all’attività degli intermediari, questi testi devono essere rinforzati. In effetti, il principio di territorialità che deriva dalla sovranità degli Stati implica che la legislazione italiana si applichi solo agli intermediari residenti in Italia quando le armi transitino attraverso l’Italia. Così uno straniero che compia integralmente all’estero la cessione delle armi non è punibile per la legislazione italiana. Questa costituisce la prima lacuna della regolamentazione attuale. D’altro canto, il principio di extraterritorialità consentirebbe l’applicazione della regolamentazione italiana relativa alle attività degli intermediari anche nel caso in cui queste abbiano luogo fuori dal territorio italiano. È opportuno regolamentare questa materia anche nel nostro paese. Il viceministro Intini ha sostenuto alla Camera il 16 maggio scorso che Ministero sta lavorando per favorire l’adozione in Italia di una regolamentazione delle attività di intermediazione (brokering) di armi. Ha ricordato la posizione comune del Consiglio dell’Unione Europea 2003/468/CFSP del 23 giugno 2003 che suggerisce a tutti gli Stati membri di fornirsi di legislazioni specifiche in materia, nella consapevolezza che un controllo sulle esportazioni di armi non può ignorare quelle transazioni che, pur non prevedendo il transito fisico di questi materiali attraverso il territorio dell’Unione, vedono società o cittadini comunitari coinvolti nel trasferimento tra Paesi terzi di armi per le quali le leggi nazionali prevedono il rilascio di specifiche licenze. A questo fine, prosegue Intini, stanno lavorando il nostro ministero della Giustizia e degli affari esteri, ad un disegno di legge teso alla definizione degli strumenti più idonei per inserire anche nella legislazione italiana il controllo dell’intermediazione in materia di armamenti.
Il conflitto d’interessi
La Relazione non riferisce nulla sulla prassi stabilitasi negli ultimi anni all’interno di Finmeccanica di nominare ex-Capi di Stato Maggiore come Presidenti o membri dei Consigli di Amministrazione di imprese militari perché è stato formalmente rispettato l’art. 22 della legge 185/90. Ma, al di lá dell’aspetto giuridico, vi è una prioritaria esigenza politica ed etica da soddisfare: queste nomine creano una zona d’ombra sui rapporti fra industria “fornitrice” e Stato “cliente” che bisognerebbe rimuovere ed evitare in futuro. Tenendo conto che circa l’85% delle attivitá industriali italiane sono controllate da Finmeccanica e Fincantieri, la prima partecipata al 30% dallo Stato e la seconda quasi completamente, sarebbe molto semplice risolvere il problema invitando il Ministro dell’Economia a fare presente ai vertici delle due societá il proprio orientamento contrario a tali nomine e a dare le opportune conseguenti istruzioni ai suoi rappresentanti nei due CdA. Anche in questo caso sarebbe opportuna un’iniziativa parlamentare che richiamasse l’attenzione del Governo su questo tema.
Le transazioni bancarie
E’ ancora San Paolo-Imi la regina delle “banche armate”. Nel 2006 sui conti dell’istituto torinese sono transitati ben 446 milioni di euro frutto di transazioni internazionali per la compravendita di armi. L’anno precedente erano 164 milioni. San Paolo ha canalizzato circa un terzo dei flussi di cassa del settore, che nell’ultimo anno sono cresciuti del 32% circa, passando da 1,125 a 1,492 miliardi di euro.A seguire le altre tra cui il gruppo BNP-Paribas, Unicredit, Banca nazionale del lavoro (Bnl), Banca Intesa, Banco di Brescia ed anche Banca popolare di Milano.
Considerazioni conclusive
Dalla lettura -non semplice- della relazione 2007 sulla 185 risulta assolutamente rimossa e smarrita la ratio ispiratrice della stessa legge. Fino dalla parte iniziale della relazione del Governo (pg. 6) si espone il proposito di “coniugare le riconosciute esigenze di sicurezza e di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale con la tutela del comparto industriale per la difesa” nulla dicendo di quali provvedimenti vadano adottati per contrastare il riarmo come previsto dall’art. 1 terzo comma. Se questo dato è coerente rispetto alla politica dell’attuale governo (aumento delle spese in armamenti) costituisce una grave ferita rispetto al programma della coalizione che questo stesso governo sostiene. Non solo: aspetti già denunciati nell’esame della relazione al Senato dello scorso anno (benché non si sia stata una relazione conclusiva) non sono stati affatto presi in considerazione. La legge 185/90 è stata ed è una buona legge: occorrerebbe applicarla in tutte le sue norme.
Nota: si propongono audizioni delle associazioni che sostengono la legge 185 ( art. dell’ On. Silvana Pisa-Ulivo. Senato della Repubblica Italiana )
 Mostra personale di Silvia Rea Titolo: “Volti e Risvolti “presentata da Carlo Roberto Sciascia curata da Joanna Wrobel . Luogo: Studio Arti e Decorazioni “Le Muse”, via Toledo n.272 – Napoli .Inaugurazione: venerdì 20 febbraio, ore 18.30 Durata: 20 febbraio – 6 marzo 2009 Orario: da lunedì a venerdì 17.00/20.00
Mostra personale di Silvia Rea Titolo: “Volti e Risvolti “presentata da Carlo Roberto Sciascia curata da Joanna Wrobel . Luogo: Studio Arti e Decorazioni “Le Muse”, via Toledo n.272 – Napoli .Inaugurazione: venerdì 20 febbraio, ore 18.30 Durata: 20 febbraio – 6 marzo 2009 Orario: da lunedì a venerdì 17.00/20.00








 Oggi si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia di Gesù, Francesco e Giacinta, apparve per sei volte la Madonna che lasciò loro un messaggio per tutta l’umanità. Il vescovo di Leiria, nella sua lettera pastorale a chiusura del cinquantenario, ha affermato che messaggio di Fatima “racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana…”. Martirologio Romano: Beata Maria Vergine di Fatima in Portogallo, la cui contemplazione nella località di Aljustrel come Madre clementissima secondo la grazia, sempre sollecita per le difficoltà degli uomini, richiama folle di fedeli alla preghiera per i peccatori e all’intima conversione dei cuori. Dopo
Oggi si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia di Gesù, Francesco e Giacinta, apparve per sei volte la Madonna che lasciò loro un messaggio per tutta l’umanità. Il vescovo di Leiria, nella sua lettera pastorale a chiusura del cinquantenario, ha affermato che messaggio di Fatima “racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana…”. Martirologio Romano: Beata Maria Vergine di Fatima in Portogallo, la cui contemplazione nella località di Aljustrel come Madre clementissima secondo la grazia, sempre sollecita per le difficoltà degli uomini, richiama folle di fedeli alla preghiera per i peccatori e all’intima conversione dei cuori. Dopo  tre apparizioni di rilievo della Vergine Maria, verificatesi durante il XIX secolo, a La Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a Castelpetroso nel 1888, la Madonna apparve nel 1917, la prima nel XX secolo, a Fatima in Portogallo. In tutte queste apparizioni, come pure nel 1432 a Caravaggio e nel 1531 a Guadalupe in Messico, la Vergine si rivolse a ragazzi o giovani di umili condizioni sociali, per lo più dediti alla pastorizia; indicando così la sua predilezione per le anime semplici e innocenti, a cui affidare i suoi messaggi all’umanità peccatrice, invocandone il pentimento, esortandola alla preghiera, chiedendone la consacrazione al suo Cuore e la riparazione alle offese fatte al divin Figlio.
tre apparizioni di rilievo della Vergine Maria, verificatesi durante il XIX secolo, a La Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a Castelpetroso nel 1888, la Madonna apparve nel 1917, la prima nel XX secolo, a Fatima in Portogallo. In tutte queste apparizioni, come pure nel 1432 a Caravaggio e nel 1531 a Guadalupe in Messico, la Vergine si rivolse a ragazzi o giovani di umili condizioni sociali, per lo più dediti alla pastorizia; indicando così la sua predilezione per le anime semplici e innocenti, a cui affidare i suoi messaggi all’umanità peccatrice, invocandone il pentimento, esortandola alla preghiera, chiedendone la consacrazione al suo Cuore e la riparazione alle offese fatte al divin Figlio.

 Omaggio da parte dei gestori del coordinamento redazionale del nostro portale provinciale: “Alto Casertano-Matesino & d” al Leader della Nonviolenza e difensore dei diritti civili del popolo indiano, il Premio Nobel per la Pace: “Mohandas Karamc hand Gandhi “
Omaggio da parte dei gestori del coordinamento redazionale del nostro portale provinciale: “Alto Casertano-Matesino & d” al Leader della Nonviolenza e difensore dei diritti civili del popolo indiano, il Premio Nobel per la Pace: “Mohandas Karamc hand Gandhi “






 NEW YORK, Stati Uniti – Un uomo che si arrabbia facilmente al lavoro può suscitare ammirazione, mentre una donna che mostra la sua ira in ufficio è vista come “fuori controllo” e incompetente, secondo uno studio pubblicato oggi negli Stati Uniti. Si tratta della ricerca di Victoria Brescoll, dottoranda all’università di Yale, intitolata “Quanto possono fare strada le donne arrabbiate?”. Nella tesi- che potrebbe avere implicazioni per Hillary Clinton nella sua corsa alla presidenza- si legge che l’anno scorso la Clinton è stata descritta da un leader repubblicano come “troppo arrabbiata per essere eletta presidente”. Ricerche precedenti hanno mostrato che con la rabbia un individuo può comunicare di sentirsi autorizzato a dominare gli altri, e quindi instaurare la convinzione che probabilmente lo è. La dottoranda ha condotto tre test in cui uomini e donne presi casualmente guardavano un video di un colloquio di lavoro, dopodiché veniva loro chiesto di valutare il candidato e assegnargli un possibile stipendio. In uno di essi, ad esempio, i copioni del video erano identici tranne quando il candidato diceva di sentirsi arrabbiato o triste per aver perso un cliente a causa del ritardo di un collega ad una riunione. I partecipanti al test hanno attribuito, nell’ordine, uno status maggiore all’uomo che diceva di essere arrabbiato, seguito dalla donna che diceva di essere triste, dopodiché l’uomo che si dichiarava triste, e per ultima, con significativo margine di differenza, la donna che diceva di essere arrabbiata per la perdita del cliente. Brescoll ha detto che le scoperte rivelano un “difficile paradosso” per le donne sul lavoro – mentre per gli uomini la rabbia può servire come uno strumento di acquisizione di status, le donne dovrebbero comportarsi con calma per essere riconosciute come persone razionali. (Fonte: Reuters)
NEW YORK, Stati Uniti – Un uomo che si arrabbia facilmente al lavoro può suscitare ammirazione, mentre una donna che mostra la sua ira in ufficio è vista come “fuori controllo” e incompetente, secondo uno studio pubblicato oggi negli Stati Uniti. Si tratta della ricerca di Victoria Brescoll, dottoranda all’università di Yale, intitolata “Quanto possono fare strada le donne arrabbiate?”. Nella tesi- che potrebbe avere implicazioni per Hillary Clinton nella sua corsa alla presidenza- si legge che l’anno scorso la Clinton è stata descritta da un leader repubblicano come “troppo arrabbiata per essere eletta presidente”. Ricerche precedenti hanno mostrato che con la rabbia un individuo può comunicare di sentirsi autorizzato a dominare gli altri, e quindi instaurare la convinzione che probabilmente lo è. La dottoranda ha condotto tre test in cui uomini e donne presi casualmente guardavano un video di un colloquio di lavoro, dopodiché veniva loro chiesto di valutare il candidato e assegnargli un possibile stipendio. In uno di essi, ad esempio, i copioni del video erano identici tranne quando il candidato diceva di sentirsi arrabbiato o triste per aver perso un cliente a causa del ritardo di un collega ad una riunione. I partecipanti al test hanno attribuito, nell’ordine, uno status maggiore all’uomo che diceva di essere arrabbiato, seguito dalla donna che diceva di essere triste, dopodiché l’uomo che si dichiarava triste, e per ultima, con significativo margine di differenza, la donna che diceva di essere arrabbiata per la perdita del cliente. Brescoll ha detto che le scoperte rivelano un “difficile paradosso” per le donne sul lavoro – mentre per gli uomini la rabbia può servire come uno strumento di acquisizione di status, le donne dovrebbero comportarsi con calma per essere riconosciute come persone razionali. (Fonte: Reuters)






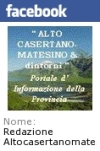

















Devi effettuare l'accesso per postare un commento.